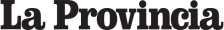Il coronavirus ci ha fatto riscoprire improvvisamente, senza preavvisi, in modo brutale e doloroso, la dimensione dell’incertezza: l’incertezza del futuro che si traduce in eventi ed appuntamenti rimandati, abitudini stravolte, nell’impossibilità di fare programmi.
L’incertezza fa parte della vita anche se per nostra comodità, quasi per volerla esorcizzare, l’abbiamo scotomizzata.Nessuno considera più che la vita può cambiare da un momento all’altro, senza che questo possa essere previsto o prevenuto; ad esempio basta un colpo di sonno del guidatore dell’auto che procede in senso opposto, basta un cornicione che si stacca proprio mentre esci da un negozio e ti colpisce, basta una mutazione genetica che da inizio ad un processo neoplastico …
La certezza è comoda e tranquillizzante, e per questo tanto desiderata, l’incertezza invece ci disturba e ci crea paure.
La gente è abituata alla certezza, anzi la pretende quasi si trattasse di un diritto: certezza del cibo (bisogno primario), che non deve più essere né cacciato né coltivato, certezza della vita (salute) e della sicurezza sociale, certezza del posto di lavoro (il tanto magnificato posto fisso), certezza che le cose funzionino come sempre hanno funzionato (certezza delle abitudini: lavoro, culto, sport, trasporti, riunioni e convegni), certezza della casa, certezza di una vecchiaia tranquilla (fondata sul risparmio in banca).
Invece è bastato un virus con una particolare corona, un insignificante frammento di RNA di pochi nano micron, un essere che non ha neppure la dignità di un DNA proprio, ma deve sfruttare quello dell’ospite che infetta, per mandare tutto all’aria.Le nostre certezze sono improvvisamente crollate, sgretolate o svanite, e questo ci fa sentire impotenti perché culturalmente siamo impreparati ad affrontare la dimensione dell’incertezza.
In verità, noi medici siamo un po’ privilegiati perché quotidianamente, nell’esercizio della nostra professione, ci dobbiamo confrontare con l’incertezza: l’incertezza della diagnosi e l’incertezza delle cure. Abbiamo coniato il concetto di fattori di rischio, che sono tutte le evenienze che possono determinare una malattia, nel tentativo di capire e quantizzare le incognite di alcune patologie.
Ma sappiamo che non è così perché abbiamo a che fare con la realtà della certezza probabilistica, che ammette quindi l’eccezione, l’anomalia, la singolarità, il caso particolare. Questo è ben presente a tutti i medici e scienziati e può essere ricondotto al concetto socratico di conoscenza limitata (so di non sapere) o al principio cartesiano dell’importanza di dubitare (“abbi dubbi”, Edoardo Bennato).
Ad esempio, sappiamo, come uomini di scienza, che l’assioma “tutti i corvi sono neri” è vero solo se si esaminano tutti i corvi che volano, quelli che hanno volato in passato e quelli che voleranno in futuro. Perché ci potrebbe essere un corvo bianconero (senza offesa per gli juventini) o un corvo tutto bianco.
È il problema della verità scientifica, o se vogliamo del concetto filosofico di verità, che va dal “tutto è vero” al “niente è vero”. L’incertezza, cioè la non certezza, fa parte del metodo scientifico stesso, che fonda proprio la sua evoluzione sulla confutazione di certezze che sembravano incrollabili e inconfutabili (vedi l’ingente lavoro di Popper). Qualche esempio: la certezza della terra al centro dell’universo che fu smentita nel ‘500 da Copernico, oppure la più moderna certezza della radicalità oncologica della mastectomia allargata che fu smentita dalla quadrantectomia di Veronesi.
La dimensione dell’incertezza è comunque presente in tanti ambiti che ci sono più o meno familiari: in economia, basti pensare all’incertezza degli investimenti e dell’andamento dei mercati finanziari, nelle previsioni meteorologiche, in ingegneria e nella metrologia, dove è prevista ed accettata la possibilità di errore nelle misurazioni, in fisica, dove l’incertezza è stata elevata a principio, come il principio di indeterminazione di Heisenberg della meccanica quantistica, che in sintesi esprime l’impossibilità per un osservatore di conoscere posizione e velocità di una particella di un sistema senza perturbarlo. A volte l’incertezza è ricercata come stimolo, ad esempio nel gioco d’azzardo, dove il caso è un elemento centrale.
In conclusione questo maledetto coronavirus, oltre alla paura del contagio, della malattia e della morte, ci ha (ri)proposto, in modo chiaro ed inequivocabile, l’incertezza della vita, dimensione alla quale non eravamo, per nostra comodità, più abituati.
Ci ha fatto (ri)prendere coscienza della nostra precarietà e fragilità, e dalla nostra dipendenza da eventi casuali, che non possiamo completamente controllare nonostante la nostra scienza sempre più evoluta e il nostro progresso tecnologico, dei quali siamo orgogliosi e fieri, fino a rasentare una imprudente superbia (vedi il mito di Icaro).
Questo contrasto tra una fede smisurata nella scienza e nella tecnologia e l’impotenza e l’incapacità di far fronte comunque alle minacce dell’imponderabile e del caso, ha (ri)generato il sentimento di incertezza, che, quando riconosciuta ineluttabile ed insuperabile, può avere una pericolosa tendenza destruente, mentre dovrebbe spingerci a trovare assicurazioni profonde e solide per un’esistenza felice.
«L’incertezza è l’habitat naturale della vita umana, sebbene la speranza di sfuggire ad essa sia il motore delle attività umane. Sfuggire all’incertezza è un ingrediente fondamentale, o almeno il tacito presupposto, di qualsiasi immagine, composita della felicità. È per questo che una felicità autentica, adeguata e totale sembra rimanere costantemente ad una certa distanza da noi: come un orizzonte che, come tutti gli orizzonti, si allontana ogni volta che cerchiamo di avvicinarsi a esso.» (Zygmunt Bauman)
* Chirurgo senologo, Direttore Unità di Senologia dell’Ospedale di Gravedona
Membro Comitato Scientifico dell’Accademia di Senologia “Umberto Veronesi”
© RIPRODUZIONE RISERVATA