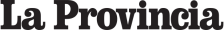L’ultimo scandalo che investito Roma e larga parte della politica italiana (quale che possa essere la fondatezza delle accuse, su cui farà luce la magistratura) richiama nuovamente l’attenzione sulla perenne Tangentopoli nazionale.
Dinanzi all’ennesimo svelarsi dell’intreccio tra affari e politica, i più tendono a evocare l’esigenza di un’etica pubblica. Il che è corretto, ma anche in parte pericoloso. Se da un lato è vero che per uscire dalla corruzione è necessaria anche una nuova cultura (più rispettosa delle regole morali elementari), bisogna però
evitare che l’ideologia della statualità moderna colga questa occasione per imporsi quale ricetta salvifica. Già oggi, nelle scuole e non solo, si assiste a un moltiplicarsi di riti volti a celebrare il potere pubblico e la legalità: con celebrazioni che esaltano – ad esempio – il dovere di pagare le imposte e si propongono d’inculcare una visione dogmatica e illiberale dei rapporti sociali.
In troppe circostanze gli appelli volti a “moralizzare” la società per purificarla e in qualche modo salvarla sono il preludio a processi di manipolazione delle coscienze che puntano ad affermare una sorta di religione civile e intendono esaltare lo Stato, in qualche modo sacralizzandolo.
Al contrario, possiamo iniziare a sconfiggere la corruzione se ci impegniamo a ridurre l’area di intervento dello Stato e tagliare la spesa pubblica. Quanto minore sarà il denaro in vario modo gestito e distribuito dai politici e dalle aziende statali, tanto minori saranno le possibilità – per i disonesti – di appropriarsene in modo scorretto. È quanto mai banale, ma “meno appalti” comporta anche “meno mafie degli appalti”.
Bisogna anche aggiungere che lo statalismo in quanto tale tende a minare la società nelle sue fondamenta, poiché dissolve ogni senso di responsabilità. Nella Politica di Aristotele si legge che “di ciò che è di tutti non si prende cura nessuno”. Il che significa, ad esempio, che ognuno di noi è molto più preoccupato di evitare che nessun ladro gli entri in casa che non di proteggere dal saccheggio di politici e malfattori quel patrimonio pubblico di cui – almeno in linea teorica – è titolare nella quota di un sessantamilionesimo. Trasferire ai privati molti compiti e proprietà che oggi sono statali produrrebbe subito una contrazione di questa delinquenza.
Ma c’è di più. In una società ad ampia presenza dello Stato perfino i privati tendono a comportarsi peggio. Dove la burocrazia statale si fa pervasiva, un’attitudine al cinismo e una certa mancanza di serietà diventano un costume condiviso, come il disinteresse per gli sprechi e per ogni capacità di mettersi al servizio del cliente. Al contrario, dove il privato prevale sul pubblico succede l’opposto, e anche gli apparati statali sono portati a imitare, nel loro agire, la dolce civiltà del commercio.
“Meno Stato” è la strada più rapida e più sicura per sconfiggere la corruzione. Allora forse non è un caso che molti fautori dello Stato sociale, della solidarietà pubblica e del ruolo regolatorio dei poteri pubblici finiscano spesso al centro di inchieste. Statalismo e malaffare sono due facce della medesima medaglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA