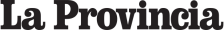Cultura e Spettacoli
Lunedì 15 Febbraio 2010
L'eroico figlio della Sarfatti
caduto al fronte a soli 17 anni
Roberto volle con tutte le sue forze arruolarsi volontario del 1917
La madre commissionò un monumento funebre a Giuseppe Terragni
Il busto di Roberto Sarfatti, scolpito da Nino Clerici, genio ribelle, ha una storia poco o nulla conosciuta. L'opera partecipò al concorso nazionale, indetto nel 1934 da Margherita Sarfatti per onorare la figura del figlio, la più giovane medaglia d'oro italiana della Grande Guerra, caduto neppure diciottenne nel gennaio del 1918. La scultura di Clerici, ancorché splendida e quasi michelangiolesca, fu giudicata tuttavia meno meritevole del busto realizzato dal bresciano Pietro Repossi, che vinse il primo premio (l'artista comasco si classificò al terzo posto). Ancora oggi, il volto bronzeo di Roberto Sarfatti è ammirato e fotografato da milioni di persone che visitano il Museo del Vittoriano di Roma.
La figura dell'eroico figliolo di Margherita si situa al crocevia delle vicende di artisti comaschi che occupano un posto di rilievo nella cultura Novecento. Non solo i due Clerici, zio e nipote, ma anche Giuseppe Terragni, che progettò ed eresse il monumento funebre di Roberto Sarfatti. Nato a Venezia nel maggio del 1900, il primogenito della scrittrice che amò il Duce aveva un temperamento irrequieto: somigliava anche fisicamente alla madre, che nutriva per lui una sfumatura di predilezione. A nove anni, i genitori lo mandarono a studiare all'Istituto Ravà di Venezia, dove si segnalò per la sua impertinenza. A causa della sua insofferenza alla disciplina, Roberto fu espulso da diverse scuole del Regno.
Il 24 maggio 1915, quando l'Italia entrò in guerra, il giovane aveva soltanto quindici anni. La notte precedente era rimasto insonne e scrisse una lettera al padre, con lo spirito traboccante di ardore dopo che il re aveva ordinato la mobilitazione. Fu difficile, se non impossibile, per i genitori, calmare i bollenti spiriti di Roberto. Il ragazzo, nel luglio del '17 partì infatti volontario nel corpo degli Alpini. Svolse il periodo di addestramento nel 6° Reggimento degli Alpini, a Caprino Veronese, poco distante dal lago di Garda. Il 25 ottobre, la notizia del crollo del fronte, a Caporetto, trasformò in un impulso irrefrenabile l'ansia di Roberto di raggiungere il fronte. Il giorno 30, concluso l'addestramento, il suo reparto di reclute ricevette l'ordine di partire per la zona di combattimento. Il 21 novembre, il giovane Sarfatti e i suoi commilitoni raggiunsero il Battaglione «Monte Baldo» e si acquartierarono alle pendici del Monte Fior, qualche chilometro a est del Monte Grappa, sopra la valle del Brenta. I primi giorni di dicembre, il Battaglione di Roberto raggiunse le alture del Sasso Rosso, controllando le cime circostanti. Fu impresa ardua mantenere le posizioni, sotto il martellamento degli austrotedeschi, ma Roberto volle resistere in vetta al Sasso Rosso, unendosi alla retroguardia di 150 Arditi, mentre osservava il ripiegamento degli alpini. Ma anche per le truppe scelte giunse l'ordine della ritirata. Il 23 dicembre, gli eserciti imperiali ripresero il Sasso Rosso e le alture vicine. A gennaio, giunse a Milano per una licenza di un paio di settimane. Poté così riabbracciare per l'ultima volta la madre e i suoi cari.
Alle prime ore del 28 gennaio 1918, suonò la tromba della riscossa. La compagnia di Sarfatti, preceduta da un intenso fuoco di artiglieria, iniziò a muoversi sul fronte orientale del col d'Echele, per conquistare Quota 1039, tre-quattro chilometri a sudovest del Sasso Rosso. Alle 9,30, i mortai diressero il tiro sulle postazioni nemiche, cosicché Roberto e i suoi compagni potessero aprire un varco. Il ragazzo strisciò fino al filo spinato colpendolo con il calcio del fucile. Finalmente, riuscì a penetrare oltre. Quota 1039 era a non più di trenta metri di distanza. Dalla trincea scavata al di sotto della sommità, i nemici cominciarono a concentrare il fuoco sul giovane caporale degli alpini. Ma Roberto, schivando i colpi, scattò su per il pendio. Galvanizzati dal suo esempio eroico, i compagni superarono tutti il filo spinato. Roberto balzò nella trincea e ne attaccò i difensori alla baionetta: trenta austriaci si arresero subito gettando a terra i fucili e lasciando agli italiani una mitragliatrice.
Gli autroungarici ripiegarono sul fronte opposto della montagna e lì occorreva stanarli. I primi ad avanzare furono gli Arditi, seguiti dal plotone d'assalto del battaglione di Roberto. Una mitragliatrice arrestò momentaneamente gli italiani. Urlando agli Arditi di seguirlo, Roby si lanciò verso il luogo da cui partiva il mitragliamento. Una pallottola lo colpì in pieno viso, stroncando all'istante la sua giovane vita. Sarfatti crollò a terra e spirò tra le braccia di un compagno ferito.
Prima che il corpo del diciassettenne fosse calato in una tomba anonima, uno dei commilitoni tagliò una ciocca di capelli dalla testa insanguinata di Roberto e la spedì a Margherita.
Nell'agosto del 1934, la Sarfatti ricette la notizia che nel cimitero militare di Stoccareddo, distante pochi chilometri dal luogo del sacrificio di Roberto, erano state individuate le sue spoglie. Margherita decise di affidare a un giovane architetto che stimava, il comasco Giuseppe Terragni, l'incarico di erigere, in prossimità della cima del Col d'Echele, un monumento funebre al figlio. La lady protettrice delle arti aveva conosciuto Terragni, non ancora assurto alle vette della celebrità, in occasione della seconda mostra del Novecento italiano che si inaugurò nel palazzo della Permanente, a Milano, il 24 febbraio 1929. Il monumento venne inaugurato il 13 ottobre del '35.
Roberto Festorazzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA