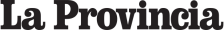Cultura e Spettacoli
Venerdì 30 Settembre 2011
Il pensiero nativo della Arendt
nel libro di una filosofa comasca
Alessandra Papa, docente nei licei e ricercatrice al Centro di Ateneo di Bioetica dell'Università Cattolica, firma il più completo saggio sulla "natality", potente categoria politica della pensatrice tedesca. Da oggi in libreria, edito da Vita e Pensiero, è già considerato un testo di riferimento per gli studi sulla filosofa meglio nota per gli scritti sul totalitarismo.
Per capire la gravità della crisi che stiamo vivendo, varrebbe forse la pena di ritornare ad Hannah Arendt (1906-1975). Non tanto ai celebri testi sul totalitarismo, ma alla (meno nota) filosofia della nascita, autentica risposta ai tempi bui in cui ci troviamo. Perché se venire al mondo è il primo esercizio di libertà e di novità, è soprattutto ai giovani che la "polis" ha l'esigenza di volgersi per offrire una politica autenticamente umana. Lì risiede la garanzia della speranza, perché sono i «neoi, i nuovi, che salvano il mondo», come ricorda Alessandra Papa, in "Nati per incominciare. Vita e politica in Hannah Arendt". Quanto una simile prospettiva sia lontana - oggi - dalle agende della scuola, dell'economia e del lavoro, è purtroppo sotto gli occhi di tutti.
Con uno scandaglio degno di un cercatrice di perle, la studiosa comasca ricompone e declina la teoria della "natality" (elaborata a partire dal 1952), consegnando un testo di riferimento per quanti si occupano del pensiero di Arendt. Il valore della ricerca della filosofa Papa, docente nei licei e ricercatrice al Centro di Bioetica dell'Università Cattolica, risiede nel provare che la vita è per Arendt la categoria politica per eccellenza. Non solo, come nota Adriano Pessina nell'introduzione, ribaltando la chiave di lettura della biopolitica di Foucault (per Arendt si tratta di garantire la vita garantendo la politica), ma aprendo fertili scenari umanistici, che spaziano dal ripensamento dell'infanzia al pensiero della differenza, dall'inquadramento del dolore quale conseguenza del venire al mondo, ai pericoli bioetici nella società della techne. Agli antipodi del suo maestro Martin Heidegger, che interpretò l'uomo come un essere-per-la-morte, la Arendt fa del venire al mondo la chiave per leggere l'agire umano: chi nasce entra in una comunità, e mediante la parola, si pone in relazione con gli altri, nello spazio della politica. Alessandra Papa spiega come la filosofa - che si definì "pensatrice politica", ma qui troviamo spesso definita "fenomenologa", in virtù di un autentico esercizio dei tratti essenziali della condizione umana - si smarchi da Heidegger e faccia riferimento a San Tommaso, oltre che al ben noto Agostino, protagonista della sua tesi di dottorato.
Con solidi argomenti la studiosa comasca mostra anche la novità del pensiero della "natality" rispetto alle teorie classiche dell'origine, di matrice greca. Se c'è un precursore, per così dire, del valore politico del nascere, va forse cercato in Virgilio, nel "puer" della celebre quarta Ecloga, a lungo interpretato come annuncio cristiano. Molto acuto il rapporto evidenziato nel saggio tra nascita, inizio e meraviglia, che illumina il venire al mondo come esercizio di senso, tipicamente umano. Proprio questo legame tra nascita, interrogazione, azione, fornisce alla Papa gli argomenti per sostenere l'aridità della vita manipolata, portando spunti nuovi, antropologici e politici, al dibattito biogenetico. Il confronto tra il bambino arendtiano e "le fils du tonnerre" (il figlio del tuono) di Sartre è una delle perle grezze su cui ha lavorato l'autrice, in un dialogo serrato con le fonti, iniziato nel '93 con la pubblicazione della tesi di laurea, dedicata proprio al tema della "natality". Il saggio è degno di essere tradotto per l'originalità dell'approccio e i percorsi di ricerca che apre, sintomo della abilità di Alessandra Papa di consegnare al pensiero di Arendt una "seconda nascita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA