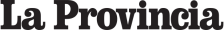Cultura e Spettacoli
Mercoledì 20 Maggio 2009
Moravia e la spia Antonini
nel nuovo libro di Festorazzi
Il narratore fu amico dell'uomo che controllava Carlo Rosselli a Parigi. In un libro il giornalista comasco ricostruisce una vicenda quasi sconosciuta che ispirò il romanzo "Il Conformista", da cui Bertolucci trasse un celebre film. Per gentile concessione dell'editore Rubbettino pubblichiamo l'introduzione al volume (257 pagine, 15 euro).
di Roberto Festorazzi
Ancora oggi, la vulgata storiografica insiste nel qualificare il delitto dei fratelli Rosselli come un crimine politico di matrice italiana: una sorta di prosecuzione, all’estero, della strategia di assassinio mirata contro gli oppositori politici più irriducibili e influenti, che trovò, in Italia, la sua più efferata espressione nell’uccisione del deputato socialista Giacomo Matteotti. In realtà, se non è mai stata dimostrata la responsabilità di Mussolini quale mandante dell’omicidio Matteotti, a maggior ragione risulta una forzatura attribuire al fascismo e al suo capo l’eliminazione di Carlo e Nello Rosselli, che oltretutto si trovavano all’estero e non risultano essere due personalità politicamente omogenee e raffrontabili tra loro. Sul delitto Rosselli, tanto la magistratura francese, quanto quella italiana, nel dopoguerra, sono pervenute sostanzialmente alla medesima conclusione: il crimine venne compiuto materialmente da una squadra di sicari francesi dell’Osarn, meglio nota come “Cagoule”: un’organizzazione paramilitare con riti di affiliazione massonici e una connotazione politica tutt’altro che cristallina. Benché dichiaratamente di estrema destra, la “Cagoule” agì in realtà con finalità perlomeno contorte, con direttrici deviate, eccellendo nelle azioni di depistaggio e fornendo copertura all’attività degli agenti della nkvd sovietica che in quel tempo stava conducendo in Francia e in Spagna una vasta operazione di “decontaminazione” del terreno politico dalle scorie del trotzkismo, sulla scia delle purghe moscovite. Benché misconosciuta, esiste una verità giudiziaria sul caso Rosselli, frutto di un concorde riconoscimento delle due magistrature, quella italiana e quella francese: la responsabilità del duplice omicidio ricade sui “cagoulard”, con l’individuazione, l’incriminazione e la condanna degli esecutori materiali del crimine; niente si può affermare per certo, invece, riguardo al movente e ai mandanti dell’assassinio, rimasti in una nebulosa. Può piacere o meno, ma le cose stanno così. La “pista italiana”, tendente a rappresentare il delitto come un’operazione scientemente voluta e abilmente programmata dalla Polizia Politica di Bocchini, o da altri apparati repressivi del regime fascista, non regge minimamente alla prova dei fatti. Ciononostante, lo storico Mimmo Franzinelli, in occasione del settantesimo anniversario dell’uccisione dei Rosselli, ha pubblicato un volume schierato sulla tesi “colpevolista”, attribuendo in modo pressoché certo il delitto alla responsabilità del vertice del regime fascista, imprecando contro le zone d’ombra, ma senza fornire alcuna prova in grado di suffragare un giudizio storico così apoditticamente incontrovertibile. Ciò che fa più specie, è che Franzinelli abbia ignorato completamente le opere storiografiche che, negli ultimi vent’anni, hanno permesso di aprire nuovi varchi per acquisire elementi di conoscenza in grado di accedere alla complessità del delitto, ai suoi aspetti più oscuri e contraddittori. In particolare, sono state le indagini di Franco Bandini, autore del libro “Il cono d’ombra”, a permettere una ricostruzione inedita e sconcertante del mistero Rosselli: un testo scomodo, violentemente osteggiato dai sacerdoti officianti i riti della vulgata imperante, ma imprescindibile, sul quale Paolo Pillitteri ha costruito, anni dopo, un proprio volume, “Il Conformista indifferente e il delitto Rosselli”. Nel suo lavoro, Pillitteri, riprendendo con qualche maggiore cautela le tesi di Bandini sul delitto di matrice “sovietica”, affronta per la prima volta un tabù: quello riguardante l’atteggiamento di Alberto Moravia, cugino dei Rosselli, riguardo al delitto. Ne è derivato un ritratto impietoso del cinismo moraviano: lo scrittore, nel suo romanzo Il Conformista, dà sfogo a tutta la sua avversione nei confronti dell’ambiente del fuoruscitismo, rappresentato come un milieu di velleitari borghesi, fatalmente destinati a finire schiacciati in mezzo alle due grandi rivoluzioni politiche del Ventesimo secolo: la palingenesi fascista e quella comunista, il rosso e il nero. L’odio di Moravia per i cugini Rosselli induce Pillitteri a concludere che sia la trasposizione cinematografica de Il Conformista, l’omonimo film di Bertolucci del 1970, a svelare per intero la verità del romanzo. La macchina testuale filmica contiene le “tracce” che il segreto del conformista provano la sostanziale identificazione di Moravia con il protagonista, Marcello Clerici, l’agente della Polizia Politica mandato a Parigi per sorvegliare il professor Quadri, salvo scoprire in un secondo tempo la vera finalità della sua missione: la preparazione del delitto. Una critica compiacente verso Moravia, ha molto operato per occultare la trasparente allusione al caso Rosselli contenuta nella narrazione dello scrittore. Ma nessuno mai, prima, aveva osato affermare che, nella sua costruzione letteraria, Moravia “uccida”, simbolicamente e per metafora, il professor Quadri alias Carlo Rosselli. Tuttavia, se è vero che nel film non mancano elementi in grado di suffragare l’identificazione Moravia-Clerici, a nostro parere risulta più interessante calare lo sforzo dell’approfondimento storico in direzione della ricostruzione del contesto in cui gli avvenimenti si svolsero. Per esempio, nessuno ha mai tentato prima d’ora di delineare le esatte connotazioni umane e politiche degli agenti della Polizia Politica che sorvegliarono Rosselli, riferendo a Roma i suoi progetti e le sue valutazioni. Se lo si fosse fatto, si sarebbe scoperto che il romanzo moraviano trae spunto e ispirazione da figure realmente esistite, non solo per quel che riguarda l’ambiente del fuoruscitismo. L’autore coglie e delinea infatti nella figura di Marcello Clerici i tratti di una personalità da lui perfettamente conosciuta, fin dai tempi dell’anteguerra. Si tratta di Giacomo Antonini, un aristocratico veneziano e cosmopolita, che rappresentò l’astro nascente della Polizia Politica di Bocchini proprio negli anni compresi tra la guerra d’Etiopia e lo scoppio del secondo conflitto mondiale. Antonini risiedette a Parigi allo scopo di infiltrarsi nel centro direzionale di Giustizia e Libertà, l’organizzazione guidata da Carlo Rosselli, e di guadagnarsi la fiducia del leader antifascista. La missione di Antonini fu coronata da tale successo che Rosselli, incautamente, lo inserì nella cerchia dei suoi più stretti collaboratori, affidandogli delicati incarichi. Pur essendo certo che l’agente della Polizia Politica fu totalmente estraneo al duplice delitto consumatosi a Bagnoles de l’Orne, la fervida fantasia di Moravia ricorre al facile appiglio di Antonini mentre cerca ispirazione per tratteggiare i contorni della spia per eccellenza. Vittima dell’epurazione del dopoguerra, Antonini rimase a Parigi quale agente della Bompiani fino alla metà degli anni Sessanta.
L’ex informatore “Giacomo”, in quel frangente, agì praticamente da plenipotenziario dell’editore milanese, mantenendo i contatti con il Gotha della letteratura francese, compreso naturalmente Sartre. In quanto autore della squadra Bompiani, anche Moravia dovette ad Antonini parte del suo successo, quale scrittore tradotto in lingua francese. Lo dimostrano le lettere inedite all’amico “Giacomo” che permettono di scrivere un nuovo capitolo del complicato caso Rosselli: fino alla pubblicazione della discussa opera, “Il Conformista”, Antonini e Moravia furono in ottime relazioni. Poi, il rapporto si guastò irreparabilmente. Ora ne conosciamo la ragione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA