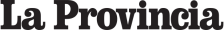Ordine / Como città
Domenica 26 Maggio 2024
Le dimore storiche primo museo d’italia
Numeri da capogiro: 35mila palazzi privati di interesse nazionale con 20 milioni di visitatori. Ben 252 si trovano nel Comasco e 149 nel Lecchese, ma Sondrio batte i capoluoghi limitrofi con 286
La rete delle dimore storiche private è stata definita come il più grande museo diffuso d’Italia. Il registro Nazionale che censisce gli immobili sottoposti al vincolo storico-artistico di proprietà privata ne raccoglie oltre 35mila, tra case storiche, palazzi, ville, casali, castelli, torri, masserie, cascine e mulini, chiese private ed ex abazie.
Una rete capace, prima della pandemia, di ospitare un numero di visitatori pari a quelli che hanno frequentato i grandi musei pubblici, ed ora in forte ripresa. Dimore che non sono ubicate solo nelle città d’arte e nei più famosi borghi storici: oltre un quarto di queste è collocato in piccoli (1,5 su dieci tra i duemila e i cinquemila abitanti) e piccolissimi comuni (una su dieci sotto i duemila abitanti) a riprova della straordinaria diffusione di questo particolare patrimonio storico. Oltre una dimora su tre risulta, inoltre, essere all’interno di un piccolo borgo storico; una su quattro in un’area rurale.
Nella sola Lombardia risultano a oggi registrati oltre 3.400 beni immobili privati dichiarati di interesse nazionale, 252 collocati nella provincia di Como, 149 nella provincia di Lecco e 286 nella provincia di Sondrio.
Il rapporto
Un universo che viene annualmente monitorato e scandagliato dall’Osservatorio Patrimonio Culturale Privato gestito dalla Fondazione Bruno Visentini con il contributo dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), Confedilizia, Confagricoltura, l’Istituto per il Credito Sportivo e naturalmente il Ministero della Cultura.
Nel IV Rapporto 2023, presentato a fine dell’anno scorso al Ministero, emerge con chiarezza un dato oramai consolidato che sfata il luogo comune secondo il quale i principali palazzi siano posseduti da fondazioni, banche e assicurazioni. Si rileva, infatti, come su cento dimore storiche oltre ottantacinque siano di proprietà di persone fisiche; dunque, a gestione familiare e una buona parte di queste siano regolarmente abitate dai suoi proprietari che svolgono il ruolo primario di custodi del bene, spesso da generazioni, con in capo tutti gli oneri per la conservazione e la valorizzazione di questo patrimonio architettonico.
Il carattere culturale, attrattivo e unico delle dimore storiche rappresenta un importante motore di spinta dell’indotto turistico a livello soprattutto locale. Una domanda, quella turistica, che, se evasa, crea opportunità di sviluppo per una vasta gamma di servizi correlati, come accoglienza, ristorazione, commercio, tour guidati e attività ricreative oltre che un impatto positivo sull’occupazione ( in particolare nella filiera del restauro e della valorizzazione dei beni storici).
Per quanto concerne la rilevazione delle aperture e visite il Rapporto stima siano oltre tredicimila le dimore che hanno svolto almeno un evento, di cui circa un quarto con ingresso gratuito, coinvolgendo poco meno di venti milioni di visitatori per il 70% di nazionalità italiana. Il dato ancora più interessante è che quasi il 40% del numero complessivo degli eventi è stato di natura culturale (se si aggiungono anche gli eventi cinematografici, si sale al 53%), a testimonianza della rilevante influenza delle dimore storiche in questa filiera. Un altro dato rilevante è l’alto tasso di destagionalizzazione dell’offerta, con oltre la metà degli eventi organizzati durante tutto l’arco dell’anno e un numero medio di aperture giornaliere pari a settanta.
Patrimonio culturale privato che, tuttavia, è ancora lungi dal poter esprimere tutto il suo potenziale se si considera che il citato Rapporto denuncia come il 47% delle dimore presenti porzioni attualmente inutilizzate causa mancanza di risorse o di ostacoli burocratico-amministrativi. Si stima, infatti, che vi siano oltre otto milioni di metri quadrati delle dimore storiche non utilizzati; superficie, per fare un esempio, che rappresenta circa 1.700 volte l’estensione dei corpi di fabbrica della Reggia di Caserta e cento volte la volumetria complessiva dell’Empire State Building.
Un patrimonio che, essendo strettamente legato all’identità del territorio dove è ubicato, ne rappresenta spesso la specificità e talvolta l’unicità. Questo vale anche per le tre province nord lombarde. In questo caso, tiene a precisare Pietro del Bono, presidente della sezione lombarda di ADSI, è possibile identificare tre realtà diverse, che prescindono dal perimetro provinciale: «Innanzitutto le ville dell’Alta Brianza, dove solo le più antiche hanno svolto funzioni agricole, mentre la maggioranza, edificate nell’800 dalle famiglie milanesi, appartengono alla categoria delle ville di delizia, realizzate in una cornice di splendidi parchi e Giardini». Ville di delizia che si trovano anche sul ramo comasco del lago.
«Le ville più antiche» precisa ancora del Bono “sono invece prevalentemente collocate a Bellagio e nella Tremezzina». Tra queste, per esempio Villa Pensiero, una splendida dimora settecentesca fronte lago. Località dove, tuttavia, si possono ammirare anche dimore più recenti, come il gioello liberty rappresentato da Villa Aureggi, realizzata a fine Ottocento sulla sponda del Golfo di Venere a Lenno e Villa Melzi d’Eril a Bellagio che non necessita di presentazione.
Infine, in Valtellina, vi sono numerosi palazzi che in origine erano castelli . «Per esempio Palazzo Vertemate Franchi, ubicato nell’abitato di Prosto, in una posizione isolata rispetto al borgo di Piuro in Valchiavenna» ricorda ancora del Bono.
Queste specificità, tuttavia, se da un lato rappresentano un’opportunità, dall’altro spesso diventano un ostacolo quando ci si confronta con le pubbliche amministrazioni in particolare regionali. «Si pensi alle concessioni spiaggia rilasciate dalla regione Lombardia, che risultano molto più onerose di quelle rilasciate dalla regione Veneto per il vicino Lago di Garda» denuncia il presidente della sezione ADSI regionale, per il quale sarebbe auspicabile una legge nazionale che riconosca deroghe proprio in funzione delle specificità territoriali.
La conservazione
In conclusione, non è poi così rilevante se la dimora storica privata sia o meno fruibile dal grande pubblico (i turisti) o per eventi ad hoc (convegni e matrimoni). Il punto centrale è assicurarne la conservazione che permetta di poterne perpetuarne l’esistenza anche per le generazioni future.
La fama in particolare del ramo comasco del lago, la Tremezzina e Bellagio è universalmente attribuita alle sue ville e ai suoi splendidi giardini che fanno della gita in battello una occasione unica nel suo genere e che fece scrivere a Sthendal «..i deliziosi dintorni di Grianta, celebrati da tutti i viaggiatori: la villa Melzi, dall’altra parte del lago, di fronte al castello, cui fa da prospettiva, più su, il bosco sacro di Sfondrata e l’arduo promontorio che separa i due bracci del lago, quello di Como così voluttuoso, quello che va verso Lecco sì pieno di austerità: aspetti sublimi e graziosi che il luogo per beltà più famoso del mondo, la baia di Napoli, eguaglia ma non supera».
La speranza, ma anche la preoccupazione, è quella di poter vantare ancora per gli anni a venire questo primato che il mondo ci invidia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA